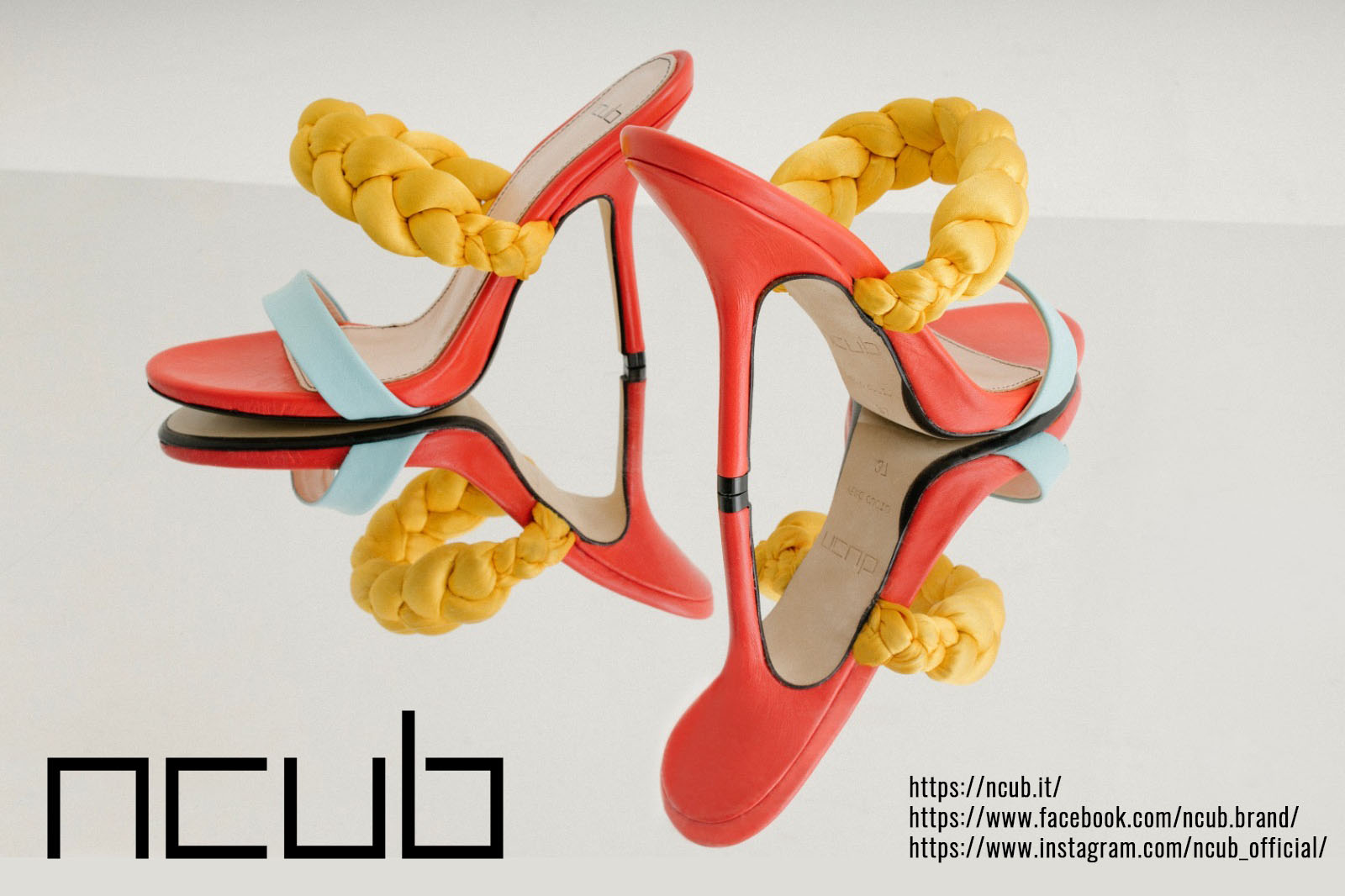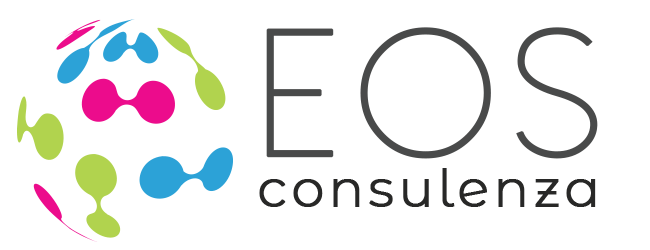Share
Apparso sulla rivista Mondoperaio nel gennaio 2012, Lo spazio dell’utopia è un viaggio tra arte e politica, un saggio sulle poche luci e sulle molte ombre della cultura contemporanea.
Di Massimiliano Perrotta
Dal Novecento l’utopia esce con le ossa rotte: la realtà ha le ossa rotte: la realtà ha vinto. Le utopie palingenetiche sono definitivamente tramontate e ancora ci circondano cumuli di macerie, strascichi attossicanti. Non sempre i sognatori sono dei candidi, a volte sono degli sterminatori.
Per taluni della mia generazione risulta alquanto difficoltoso trovare una definizione adeguata del proprio credo politico. Non comunisti perché antipatizzanti dell’Unione Sovietica quando ancora c’era, non socialisti perché il socialismo italiano è nell’accezione comune quello cosiddetto riformista.
Quando militavo in Rifondazione Comunista mi capitava talvolta di essere trattato con un certo sprezzo: tronfi della loro fede in non si sa bene quale comunismo, alcuni compagni reagivano con fastidio al mio interrogarmi su come le nostre idee potessero essere rifondate. Tra gli epiteti collezionati – «comunista all’acqua di rose», «paternalista verghiano», «uomo dell’Ottocento con il cuore in mano» – «socialdemocratico massimalista» è quello che mi piace di più. In attesa di progetti nuovi, mica male le vecchie ricette socialdemocratiche: scuole migliori, più ospedali…
Lasciai il partito quando presi atto che non si voleva rifondare il comunismo (o, come io auspicavo, la sinistra cosiddetta massimalista), ma soltanto il partito comunista.
Quanto mi mancano quelle umide stanze illuminate al neon, quell’aria sudaticcia, quei rotoli di manifesti ingialliti ammonticchiati nell’angolo più buio. E quelle parole appassionate, veementi… quegli ordini del giorno che provavano a dare un assetto logico alle nostre confuse speranze.
Il disordine mentale della sinistra contemporanea è figlio del non volersi guardare allo specchio con onestà. La storia della sinistra pullula di errori: i massimalisti si sono lasciati abbagliare dai miraggi delle dittature comuniste, i riformisti si sono fatti abbindolare dalle fole dell’iperliberismo totalitario. Ma la storia della sinistra è al tempo stesso nobilissima: ha dato un contributo decisivo alla lotta di milioni di donne e di uomini per migliorare le proprie condizioni sociali.
Niente ha danneggiato la nostra causa quanto i nostri silenzi per non danneggiare la causa.
Stanchi della lunga battaglia, cominciammo a discorrere dell’immodificabilità del reale. Nell’altra stanza i signori del capitale indisturbati si modificavano la realtà a loro comodo.
Il capitalismo a oltranza, l’ultima delle ideologie, ci ha chiesto di rinunciare ai valori perché d’intralcio all’efficienza del meccanismo produttivo. Ora, tramontando, ci lascia con le tasche e con le anime vuote.
Della morte delle ideologie c’è poco da rammaricarsi. Il Novecento ha ucciso le ideologie ma non le nostre idee che a me sembrano più necessarie che mai. Giustamente Leonardo Sciascia correggeva la celebre battuta di Woody Allen: «Dio è morto, Marx pure e io mi sento bene. Voglio continuare a vivere, voglio continuare a pensare, voglio vedere dentro le cose, voglio giudicarle per come sono e voglio essere libero».
Il mancato dialogo tra Craxi e Berlinguer che tanto ha nuociuto a Craxi e a Berlinguer nonché a tutta la sinistra italiana, rappresenta un monito per l’avvenire: quello tra sinistra riformista e sinistra massimalista è un dialogo necessario.
Affinché la sinistra sia vitale, l’utopia deve avervi uno spazio. Una sinistra arresa alla dittatura dell’esistente a lungo andare smarrisce la propria ragion d’essere. La sinistra ha bisogno dei massimalisti per additare la meta lontana e dei riformisti per condurvi la nave con saggezza.
Nella sua accezione originaria il riformismo trovava senso contrapponendosi dialetticamente al massimalismo: scendere a compromessi con la società capitalista per ottenere piccoli risultati immediati, piuttosto che aspettare il giorno in cui le condizioni fossero mature per trasformare tutto radicalmente. Oggi, sia a sinistra che a destra, molti si proclamano riformisti, di un riformismo generico che non specifica quali riforme voglia promuovere. Forse costoro vogliono solo affermare il loro non amore verso lo status quo. Ma noi progressisti ormai dovremmo saperlo bene che riformare una cosa non vuol dire necessariamente migliorarla.
Più ancora del sistema talora inquietano certi suoi contestatori, certi facinorosi rivoluzionari in peggio.
C’è anche una sinistra radicale che ha poco da farsi perdonare. Una sinistra massimalista che prese le distanze dalle tirannie comuniste per tempo e che, pur avendolo ispirato, sconfessò il Sessantotto non appena rivelò il suo volto fanatico. Parlo della sinistra francofortese: la diagnosi del «mondo amministrato» fatta da Max Horkheimer e da Theodor W. Adorno si è rivelata profetica. Eppure, per una certa sinistra quella lezione è «superata»!
Lasciare alle destre la difesa dei valori dell’occidente, cioè di molti dei valori fondativi della sinistra, è un errore dalle conseguenze incalcolate.
La cosiddetta Seconda Repubblica che così poco ci piace è la meritata espiazione collettiva per la colpa di aver distrutto con violenza la prima.
Oggi che trionfa una diffusa antipatia per la politica, oggi che questa ha finalmente abbandonato la pretesa di determinare tutto, con rinnovato entusiasmo dovremmo accostarci a essa. Sì, c’è tanto bisogno di politica: per spiegare ai giovani con quali risorse verranno pagate le loro pensioni, per cercare di capire chi dovrà assistere notte e giorno i milioni di vecchi che l’allungamento della vita va producendo, per definire quali debbano essere i limiti di una scienza sempre più in preda a deliri d’onnipotenza…
Votare non è tracciare una croce sopra una scheda elettorale: significa esprimere il proprio consenso. La democrazia non vive di rituali elettorali, vive del consenso che le diamo sentendoci rappresentati dagli esponenti politici che ci garbano.
Dal Novecento escono malconce anche le utopie degli industriali umanisti. Una tristezza indicibile vela il cielo di Ivrea, la città nella quale Adriano Olivetti provò a concretizzare la sua utopia sociale e urbanistica al servizio della comunità. Dopo la sua morte il Canavese è stato devastato da imprenditori discutibili e oggi è una zona economicamente depressa: restano un museo a cielo aperto dell’architettura moderna e il rimpianto delle nuove generazioni che dai loro vecchi ascoltano i racconti dell’età dell’oro.
Sappiamo bene che la redenzione sociale non è alla nostra portata, che le uniche redenzioni possibili sono quelle estetiche e quelle metafisiche. Eppure, non ci rassegniamo a deporre il sogno politico nel cassetto. Restiamo qui – impigliati in questo tempo nero – e sussurriamo al vento il nostro bisogno