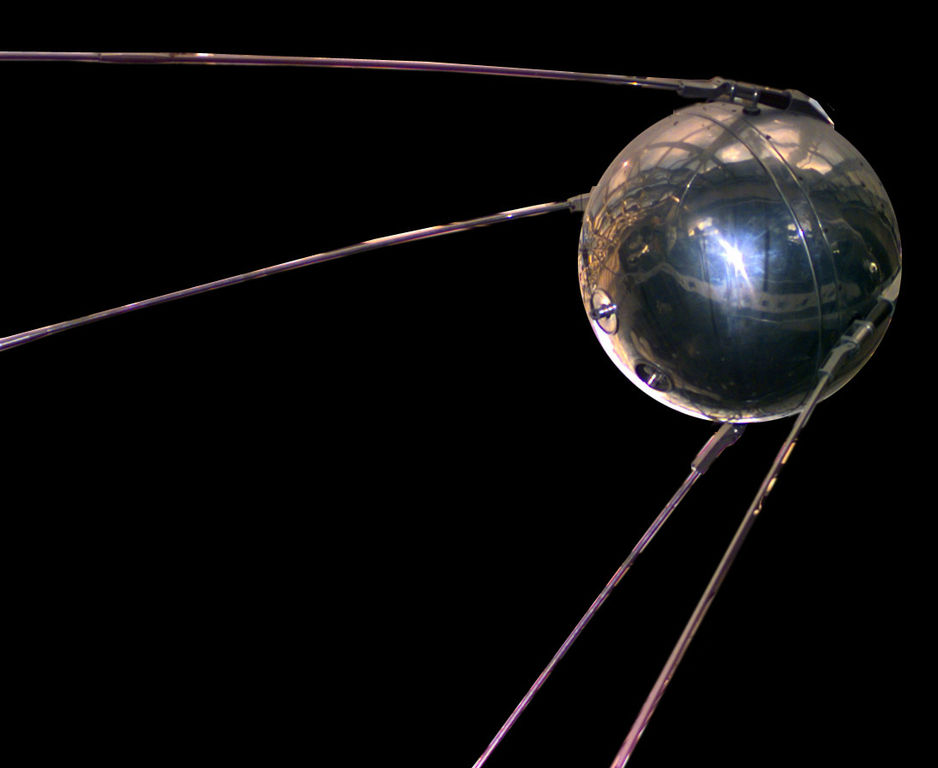Share
Confermando in larga misura le previsioni dei sondaggi, Donald Trump ha nettamente vinto i caucus dell’Iowa superando il 50% dei voti (e dei delegati). Una vittoria, questa, rafforzata dall’esito complessivo del voto, dove DeSantis – che moltissimo aveva investito in Iowa – ottiene un risultato deludente, ma non tale da escluderlo dalla contesa e da permettere così di concentrare tutto il voto anti-Trump su Nikki Haley, a sua volta incapace di andare al di là delle aspettative come invece aveva bisogno. Ora ci si trasferisce in New Hampshire, dove il 23 gennaio vi saranno primarie classiche e parzialmente aperte (potranno votare anche gli indipendenti). E dove vi sarà in teoria un elettorato più favorevole all’ex ambasciatrice all’Onu, cui i sondaggi attribuiscono circa il 30% contro il 40-45 di Trump e il 5-6 di DeSantis.
Difficile capire come Haley e ancor più DeSantis possano impedire a Trump di ottenere la nomination. Molto può accadere, certo, e nel 2020 Biden sembrava fuori dalla contesa dopo il New Hampshire e prima del South Carolina. Ma ora come ora Trump è nettamente favorito ed esce da questo primo voto ancor più rafforzato. Quali considerazioni possiamo fare sullo stato del partito repubblicano, della democrazia statunitense e di questo ciclo presidenziale? Cinque punti possono, molto schematicamente, aiutarci.
Nonostante tutto, Trump regge
Trump rimane figura centrale e per certi aspetti dominante nel confronto politico e pubblico. Tre anni fa, non votando l’impeachment, molti suoi avversari repubblicani scommisero sul fatto che sarebbe progressivamente uscito dalla politica vuoi per i suoi guai giudiziari, vuoi per il suo acclarato disinteresse verso l’arte di governo, vuoi perché la priorità sua e della sua famiglia sarebbe stata quella di capitalizzare economicamente sui quattro anni trascorsi alla Casa Bianca (cosa peraltro avvenuta, in particolare con la sconcertante vicenda del fondo d’investimento del genero, Jared Kushner, quasi interamente finanziato con soldi sauditi). Una scommessa persa, motivata dalla consapevolezza che punire Trump per la sua azione eversiva successiva al voto del 2020 avrebbe comportato un costo pesante in termini di consenso e di voti, a partire dal mid-term del 2022. E a cui si è aggiunta anche la lentezza con cui il Dipartimento della Giustizia di Biden ha deciso d’indagare Trump, finendo per far coincidere incriminazione e (futuri) processi con questo ciclo elettorale. Sia come sia, è Trump che oggi detta tempi e forme della discussione politica e mediatica, traendone al momento un evidente vantaggio, almeno nelle primarie.
L’America repubblicana sta con The Donald
Anche perché la base elettorale repubblicana – soprattutto quella più militante e motivata – è in larghissima misura schierata con l’ex Presidente. Gli stessi primi exit-poll dell’Iowa sembrano indicarlo, mostrando ad esempio come Trump sia andato meno bene con quel segmento di elettori più volubile, che solo nelle ultime settimane ha deciso se e come votare. Nel mondo conservatore, Trump non è più in alcun modo l’outsider. Non essendo granché cambiati né il suo modo di porsi né il suo lessico primitivo e binario – l’esperienza politica e di governo non lo ha civilizzato e alfabetizzato istituzionalmente – ciò significa che una parte non marginale di America è ormai pienamente “trumpizzata”. Di Trump parla la lingua, spesso violenta e incivile; ne accetta visioni, proposte politiche e, anche, paranoie e cospirazioni. I sondaggi lo evidenziano. Tra gli elettori di Trump in Iowa non più del 10% considera Biden un Presidente legittimo e crede al risultato elettorale del 2020 (una percentuale che sale al 30% se includiamo tutti i votati di questi ultimi caucus). Una delle frasi più dure (e agghiaccianti) pronunciate da Trump durante questa ultima campagna elettorale – quella secondo cui gli immigrati “avvelenerebbero”, in senso figurato e letterale, “il sangue dell’America”, importando nel paese criminalità e “malattie” – sarebbe condivisa dall’80% dei repubblicani.
Una democrazia in affanno
È chiaro che tutto ciò pone un problema evidente alla democrazia statunitense di suo già in palese sofferenza, lacerata da una polarizzazione estrema che danneggia la sua governabilità, esaspera la contrapposizione politica e fragilizza ancor più istituzioni già deboli e delegittimate. In questo contesto, anche una sfida tra candidati “normali” sarebbe destinata a produrre mesi di campagna elettorale tossica e brutale, come ci ricordano tanti esempi del passato recente (Bush sr. Vs. Dukakis nell’1988 o Bush Jr. vs. Kerry nel 2004 vengono subito in mente). E i candidati di questo 2024 tutto sono fuorché “normali”: un Presidente fiaccato dall’età, non sempre lucido, e costretto a immaginare una campagna elettorale a bassa mobilità e minimo sforzo, da un lato; un avversario (ed ex Presidente) dalle ostentate inclinazioni autoritarie, che rifiuta ancor oggi di riconoscere la sconfitta del 2020 e promette ritorsioni contro avversari politici e funzionari non allineati, dall’altro. È uno scontro di “debolezze” quello cui ci apprestiamo ad assistere che non promette nulla di buono e che espone tutta le difficoltà della democrazia statunitense e di un federalismo a sua volta lacerato da una polarizzazione che acuisce la natura conflittuale della dialettica tra poteri federale, statali e municipali.
Le radici del trumpismo: nostalgia e timore della globalizzazione
La domanda che ci si pone è come sia possibile tutto ciò. E, ancor più, come Trump possa essere ormai volto e simbolo del partito repubblicano e dell’elettorato conservatore. Sulle matrici della polarizzazione negli Usa molto è stato detto e scritto. Vi concorrono una pluralità di fattori – culturali, sociali, economici, razziali – che hanno esasperato faglie di frattura già esistenti e trasfigurato la natura dei due partiti, quello repubblicano in particolare. Un passaggio cruciale e riconosciuto è stata la grande crisi del 2008, che ha di fatto affondato una narrazione benigna della globalizzazione e, soprattutto nel caso statunitense, legittimato a Destra una nuova grammatica politica fatta di protezionismo, unilateralismo, anti-cosmopolitismo e, in taluni suoi eccessi, xenofobia, che Trump ha cavalcato e di cui si è poi impossessato. L’ex Presidente è diventato il punto di riferimento di chi, a torto o ragione, si rappresenta come vittima della globalizzazione, in particolare – e di certo più dei percettori di redditi bassi e medio-bassi – un ceto medio dai redditi stagnanti, spesso punito da una fiscalità in parte progressiva (verso il basso) e molto regressiva (a favore di alti redditi da capitale) e che nel 2008 ha visto venir meno quel fondamentale meccanismo compensativo rappresentato da consumi a debito permessi a loro volta dalla crescita dei valori immobiliari. Trump parla a un paese nostalgico di un’era edenica di alti consumi, finanza deregolamentata e facili crediti. Oltre che di un ordine garantito da inscalfibili gerarchie sociali e razziali, preservate anche grazie a politiche securitarie interne punitive e draconiane. È, nella narrazione trumpiana, una miscela tra l’America dei primi anni 2000 e quella dell’immediato secondo dopoguerra il paese che deve “essere fatto nuovamente grande” e che viene contrapposto al declino attuale. Un messaggio, questo, che cattura l’immaginario di molti. Così come cattura la violenza retorica con la quale questo messaggio viene dispiegato contro i nemici interni ed esterni: gli avversari politici, “parassiti” da “estirpare” (in un altro discorso recente); gli immigrati messicani e centro-americani; i rivali cinesi. Accanto a questo, vi sono matrici più convenzionali del sostegno a Trump. Pur nelle sue forme ruvide, il messaggio trumpiano riattiva topoi dalla grande forza mitopoietica su di un paese sempre pronto a rinascere e rigenerarsi. I contenuti della proposta politica trumpiana, in parte realizzati tra il 2017 e il 2021, sono per molti aspetti assai più ortodossamente repubblicani di quanto non si creda – tagli alle tasse, deregulation, alta spesa militare, sostegno all’industria estrattiva, nomina di giudici “originalisti”, per menzionarne solo alcuni – e contribuiscono a renderlo accettabile a molti elettori conservatori e indipendenti, magari critici nei confronti del lessico e della postura di Trump. Il realismo radicale e semplicistico in materia di politica estera piace a un paese che ha assistito al fallimento delle guerre americane del XXI secolo e alla crisi della globalizzazione, e a cui si promette di recuperare la sovranità in parte perduta. Paese che osserva talvolta con legittima perplessità il rilancio da parte democratica di un discorso e di una visione – quello molto “atlantico” e “democratico” di Biden – che pare da tempo avere esaurito credibilità e senso.
Le sfide internazionali
E questo ci porta all’ultimo punto: la politica internazionale. Che occuperà, direttamente o indirettamente, uno spazio centrale nella campagna elettorale. Dall’immigrazione all’inflazione, dalle politiche energetiche a quelle sull’educazione, il mondo entra inevitabilmente anche in temi che si tende a considerare strettamente interni. A essi si aggiunge ovviamente uno scenario globale particolarmente volatile e pericoloso, con le guerre in Ucraina e a Gaza, le tensioni sul Mar Rosso e l’impatto su catene globali che faticosamente stavano uscendo dalla transizione post-pandemica, la questione di Taiwan e tanto, tanto altro. La tesi che negli Usa esisterebbe una tradizione bipartisan in politica estera fondata sul riconoscimento di un superiore interesse nazionale è leggenda tanto persistente quanto infondata. È però vero che sulla politica estera e di sicurezza le costrizioni sono di solito più forti e i margini di manovra minori. Colpisce quindi quanto distanti se non antitetici siano anche su questo i modelli e discorsi di Biden e Trump. Una differenza che rimanda una volta ancora alla natura polarizzata del confronto politico e a quella assai peculiare di questa campagna elettorale.
Fonte: ISPI